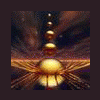1.
La vidi dove sarebbe rimasta fino alla fine. Avete presente la panchina a strisce verdi e blu di piazza Dogana, quella rivolta verso la rotonda, davanti al bar Moka? Stava seduta là, a gambe incrociate, lo sguardo fisso sui cassonetti della spazzatura sul lato di fronte. Buffo che guardasse proprio da quella parte, se si pensa a come è finita.
La vidi mentre tornavo a casa dopo una partita di calcetto al parco, sudato fradicio e imbacuccato nel giaccone pesante per non ammalarmi.
Mi avvicinai incuriosito e la prima cosa che notai fu che era carina. Occhi luminosamente vuoti, azzurri, un po’ spalancati, capelli biondo sporco; molto magra, sottile, con un sorriso appena accennato, incompiuto. Era scalza, il rosa pallido delle piante dei suoi piedi nudi faceva capolino da sotto le ginocchia. Non le diedi più di diciassette anni, l’età che avevo io allora.
Era tardo pomeriggio, uno di quei primi dolci pomeriggi di primavera, quando un vento tiepido soffia da Sud-Ovest e la città ghiacciata dal torpido sogno dell’inverno si risveglia ai raggi del sole rinato. Le vernici metallizzate delle macchine in colonna nella rotonda riflettevano la malinconica luce del tramonto. Gruppi di ragazzi e ragazze in giacche leggere, i volti arrossati dal primo sole, dopo tanto tempo tornavano ad affollarsi davanti alle gelaterie riaperte e si spingevano ridendo con aria spensierata.
Ma lei a tutto questo era estranea. Dava l’impressione di essere completamente avulsa da ciò che la circondava, lontana anni luce dal tepore e dalla primavera. Stava là e basta, come sarebbe stata chiusa a chiave in camera sua, o sul divano di una discoteca, o sul fondo dell’inferno, per quanto sembrava che gliene importasse.
Quando le passai davanti per imboccare la via in cui abitavo, qualcosa in lei mi colpì molto. OK, era carina, ma niente di eccezionale, decisamente troppo magra… No, che fosse bella non c’entrava nulla; furono i suoi occhi. Per un attimo incrociai il suo sguardo e in esso percepì allo stesso tempo un’incredibile intelligenza, immensamente superiore alla mia e a quella di chiunque altro avessi mai conosciuto e un vorticoso senso di vertigine, di vuoto assoluto. Come veder esplodere una supernova in un buco nero.
Tornai a casa turbato e quella sera a letto rimuginai a lungo su ciò che avevo visto, incapace di prendere sonno. Non riuscivo a togliermela dalla mente.
La mattina dopo andando a scuola la rividi. Era sempre seduta su quella panchina, nella stessa posizione e con lo stesso sguardo incomprensibile fisso nel nulla. Poteva non essersi mossa di un millimetro.
A scuola non ne parlai con nessuno, non mi sembrò necessario. E poi pensai che a raccontarla sarebbe parsa una cosa stupida, di poco conto, così decisi di tenerla per me. Eppure non ascoltai una sola parola di ciò che dicevano i professori e nemmeno per un secondo smisi di pensare a quella strana ragazza sulla panchina.
Non mi stupii di trovarla ancora là quando tornai a casa a ora di pranzo. Presi il cellulare e fingendo di telefonare la osservai con la coda dell’occhio per qualche minuto. Sedeva nell’immobilità assoluta. Guardandomi attorno mi accorsi con un certo fastidio di non essere il solo ad averla notata. Proprio allora dalla banca uscirono degli impiegati che la guardarono incuriositi e sul balcone di una casa che dava sull’incrocio una donna con un grembiule lillà le lanciò una lunga occhiata mentre si chinava per annaffiare i gerani sul davanzale. I soliti vecchi alcolizzati del bar Moka, alticci fin dal primo mattino, accennavano a lei con le teste e la squadravano ridendo sotto i baffi.
Quel pomeriggio inventai un pretesto per giustificarmi davanti a me stesso e tornai in piazza Dogana. Non se n’era andata. La curiosità prevalse e, fatto un respiro profondo, mi sedetti sulla panchina accanto a lei.
- Ciao – dissi sfoderando il mio sorriso più accattivante
Lei non sembrò avermi sentito. Nemmeno si girò per guardarmi in faccia, non mosse un muscolo del viso. Continuava a tenere lo sguardo fisso dritto davanti a sé, nella stessa direzione del giorno prima, verso i bidoni della spazzatura.
- Ciao – ripetei a voce più alta.
Nulla. Non dava il minimo segno di essersi accorta della mia presenza. Pensai che potesse essere sorda, o cieca, o entrambe le cose.
- Ehi, parlo con te! – Mi chinai verso di lei nella speranza di attirare la sua attenzione, ma fu inutile. Rimase immobile come una statua.
Spazientito, le misi una mano davanti agli occhi e la agitai su e giù. Nulla. Le diedi uno schiaffetto sulla guancia, poi un altro leggermente più forte. Un albero avrebbe reagito allo stesso modo.
Pensai che potesse essere morta. Si sa un corpo può rimanere per molto tempo nella posizione in cui la vita lo ha lasciato. Dopo aver dato un’occhiata circospetta alla piazza (nessuno in quel momento sembrava guardare dalla mia parte, nemmeno gli assidui del Moka) mi inginocchiai per terra di fronte a lei e la guardai bene. Non batteva le palpebre e non sembrava respirare.
Vagamente impaurito dalla possibilità di trovarmi così vicino a un morto, alzai la mano e le toccai timidamente la fronte. La tolsi di scatto, la posai di nuovo, feci il confronto con la mia.
Era calda almeno quanto me. Forse era morta da poco, avevo sentito da qualche parte che un cadavere ha bisogno di un po’ di tempo per raffreddarsi.
In preda a un’ispirazione improvvisa le presi la mano abbandonata inerte sulle ginocchia e le tastai il polso sottile. All’inizio non sentii nulla. Non riuscivo a concentrarmi a causa delle macchine che rombavano ininterrottamente a pochi metri da noi e avevo paura di attirare l’attenzione dei passanti. Molto probabilmente qualcuno nella piazza si era accorto di me e osservava ciò che stavo facendo.
Faticosamente riuscii a distogliermi dal rumore e dalle preoccupazioni e cominciai a sentire qualcosa. Più che un battito, era un lento flusso continuo, simile a al moto di una marea, ma pensai di poterlo ritenere un prova sufficiente del fatto che fosse viva.
Mi risedetti accanto a lei sulla panchina e la guardai di nuovo. Forse era in coma, dato che non batteva le palpebre, non sembrava respirare e avere coscienza di sé, ma rimaneva da chiarire come era potuta era arrivare fin lì. Forse stava proprio in quella posizione quando si era sentita male. Tipo un infarto o un ictus o qualcosa del genere.
Mi sentii in imbarazzo a stare seduto in silenzio su una panchina accanto a una ragazza seduta immobile a gambe incrociate, apparentemente morta. Scossi la testa, mi alzai e feci per tornare a casa.
- Io non ho idea di chi tu sia. – Aggiunsi intenzionata ad andarmene, ma poi mi risedetti.
- O del perché tu stia qui seduta immobile da ieri pomeriggio. – Sapevo che non poteva sentirmi e ciò che stavo facendo era completamene privo di senso, ma proseguì.
- In realtà non so nemmeno cosa ci faccio io qui con te. Escludo che tu sappia che ci sia anch’io. Non ho mai visto una cosa strana come te, sai? Te ne stai talmente immobile, con un’aria talmente distaccata che ho creduto che fossi morta. Ma non lo sei, questo è chiaro; anzi, non sei meno viva di tutti noi altri, probabilmente. – Una volta cominciato non riuscii più a fermarmi.
- Perché in fondo ora che ci penso non è che la mia vita sia particolarmente interessante, e non so quella degli altri lo sia. Per carità, non mi posso lamentare. Niente malattie, perdite importanti o sfighe vere… A rigor di logica dovrei essere felice. In teoria la felicità è una condizione negativa: se non stai male, e quindi mangi, bevi, dormi e ti senti sufficientemente libero, be’, allora stai bene, e se stai bene è ovvio che tu sia felice. Non c’è un solo motivo serio al mondo per cui non dovrei esserlo. OK, magari non riesco a farmi la ragazza che voglio, prendo un brutto voto a scuola, litigo con mia madre… Ma questa è roba che nel peggiore dei casi ti può far sentire un po’ giù, stop… Se fossero questi i problemi del mondo... No, non so… E’ solo che… Mi manca qualcosa, non so se capisci cosa intendo… Cioè, certo, è un problema mio, ma questo non vuol dire nulla, visto che stiamo parlando di me. E’ come se avessi sempre vissuto con l’impressione di perdermi qualcosa… Qualcosa d’importante, di fondamentale…
Insomma, avrete capito. Vi risparmio il resto.
Da quel giorno andai da lei tutto i pomeriggi. Parlavo, ridevo, balzavo in piedi per spiegare meglio ciò che dicevo, mi risedevo, mi entusiasmavo, mi sconfortavo... Lei era la più grande ascoltatrice che avessi mai conosciuto, compresa mia madre. Era confortante sapere di poter contare su qualcuno che non ti interrompeva e non ti contraddiceva mai, non dubitava di nulla e non faceva domande.
2.
- Ma tu non hai mai fame? – Era così che cominciavo sempre. All’inizio era una specie di gioco, ma poi divenne una preoccupazione più seria, e infine una preghiera disperato. Dimagriva di giorno in giorno, era sempre più, brutta e sciupata. Anche se guardandola era impossibile pensare che qualcosa che riguardasse anche solo lontanamente la terra e le necessità materiali potesse toccarla, credo che avesse bisogno di mangiare proprio come tutti gli altri. Vederla assottigliarsi e perdere progressivamente le forze era straziante, e in quegli ultimi terribili giorni ogni volta mentre tornavo a casa dopo che essere stato con lei faticavo a trattenere le lacrime. Un giorno portai con me del pane e, pur sapendo già prima che sarebbe stato inutile, feci un timido tentativo di imboccarla. Ma l’increspatura di quel sorriso ultraterreno non voleva saperne di aprirsi, e non ebbi il coraggio di aprirle la bocca a forza e infilarci il cibo contro quello che sembrava un suo desiderio.
Sapevo che la cosa giusta da fare sarebbe stato portarla all’ospedale o almeno avvertire qualcuno di competente. Un paio di volte la coscienza riuscì quasi a prendere il sopravvento e fui sul punto di parlarne con mio zio, che è medico, ma non lo feci mai. Mi giustificavo pensando che di sicuro non soffriva, dato che non era cosciente, che quella non poteva che essere la sua volontà e che comunque sarebbe stato impossibile aiutarla più di quanto facevo io. Non so quando o da dove mi sorse quest’idea, ma nel giro di poco mi convinsi di essere per lei una sorta di guardiano. Ero io che la facevo felice andandola a trovare tutti i giorni. Ero io, soprattutto, che cercavo di difenderla dagli assalti del mondo esterno.
Vivevo nel costante terrore che venisse il giorno in cui non l’avrei più trovata. Ero perseguitato da sogni in cui lei, stufa di me, se n’era andata e io la rincorrevo per il dedalo le viuzze della città vecchia. La cosa peggiore era che mentre la inseguivo sapevo bene che non avrei mai potuto raggiungerla. Forse intuii fin dall’inizio che il suo soggiorno sulla panchina sarebbe stato breve, e fu proprio la tacita consapevolezza di ciò a lacerarmi. Forse l’ho sempre sentita troppo estranea a tutto ciò che c’è qui per poter credere che sarebbe rimasta a lungo.
Fin dalla prima volta che la vidi mi accorsi del crescente interesse della gente nei suoi confronti. Mentre stavo con lei notai che non c’era una sola persona che passasse da quelle parti che una volta al giorno non deviasse di poco il suo percorso per guardarla. E molto spesso qualcuno quando incrociava il suo strano sguardo si fermava e fissava a lungo.
Non ero nemmeno l’unico a parlare con lei. Vidi più volte delle persone che non conoscevo avvicinarsi cercando di non farsi notare e lasciarsi cadere al suo fianco. Proprio come facevo io, le parlavano concitatamente per ore.
Sapere di non essere il solo a occuparsi di lei, a considerarla importante e soprattutto a parlarle mi rendeva geloso oltre ogni limite. Pensavo che nessuno potesse amarla nemmeno con un milionesimo dell’intensità con cui l’amavo io, che nessuno tranne me potesse capirla…Quella gente superficiale e falsa non aveva il diritto di starle vicino e intromettersi nella perfezione del nostro rapporto. Ognuno dei loro stupidi sguardi la offendeva e la insudiciava.
Un pomeriggio arrivai che sulla panchina era già seduto qualcuno. Era un ragazzo qualche anno più piccolo di me, tarchiato e con la pelle olivastra. Mi appoggiai con la schiena a un palo poco distante e rimasi ad ascoltare, gli occhi ridotti a due fessure dalla rabbia.
- Io, comunque, sono Pablo. – diceva il ragazzino con un accento straniero, facendo ampi gesti con le mani. - Cioè, in realtà Paolo, però la gente di solito mi chiama Pablo, no? Cioè per Pablo Escobar, no? Quello di Blow, presente? Non è che spaccio, eh! Lascia stare! Al limite porto le storie di mio fratello a certi tipi… E’ che è un nome figo, Pablo, no? Cioè, ha stile! Sai quanta gente che si chiama Paolo! E invece Pablo no, magari in Spagna, ma quello chissenefrega! Cioè, non è che siamo in Spagna, no? Pablo a scuola tutti sanno chi è… Solo che una volta lo ha sentito mio padre, no? Lo odio, mio padre! Comunque, vabbò non ti sto a dire tutto bene, ma mio padre ha sgamato l’Ale che mi chiamava Pablo, no? Allora le ha detto di levarsi dai ******** subito che la prossima volta le spaccava la faccia e quando lei se n’è andata mi ha dato una fracca di botte. Cioè, solo perché mi ha chiamato Pablo, no? E’ che lui dice che mi ha chiamato apposta Paolo perché quando sono nato sapeva già che poi venivamo qua in Italia, no? Perché Paolo è un nome italiano, no? E allora gli fa incazzare che non mi chiamano così, anche perché lui dice che Pablo è un nome di *****, no? Proprio una gran testa di *****, mio padre…
Non riuscii più a trattenermi e lo insultai dicendogli di andarsene subito. Se non ci fosse stata lei a farci vergognare di noi stessi non ho dubbi che saremmo passati alle vie di fatto. Molto probabilmente le avrei prese.
Un sabato notte passai di là per salutarla mentre tornavo a casa e assistetti a una scena che ricorderò per sempre. Un barbone era inginocchiato per terra di fronte alla panchina, nella stessa posizione in cui qualche giorno prima io le avevo tastato il polso. Le baciava i piedi sotto le ginocchia e piangeva.
- Io ti amo! – urlò a un tratto, la voce impastata dall’alcol – Ti amo più di quanto amavo lei! Non è possibile! Non è possibile! – singhiozzò premendo il capo sul suo grembo.
- Tu non sei lei e io non posso amarti! Perché? Perché? – Si rialzò barcollando e presa una bottiglia da terra la scagliò contro un cartello mandandola in frantumi.
- Perché? Tu non sei morta! Lei è morta e mi ha lasciato qui! Qui! – Prese da terra un’altra bottiglia e spaccatola contro la panchina si ferì la guancia con un vetro rotto. Poi con urlo disperato alzò il vetro nella sua direzione e per un secondo sembrò sul punto di ferirla, ma lo riabbassò subito e si accoccolò per terra sotto di lei, piangendo in silenzio.
3.
Due settimane dopo della creatura di sole e cielo che era stata prima non era rimasto nulla. Due enormi occhi febbricitanti si aprivano come ferite sulla sommità di un sacco d’ossa ricoperto di pelle trasparente. Era sera e una spessa coltre di nubi scure gravava sulla città. Non la guardavo, per non piangere.
- Sono due settimane che te ne stai sola su una panchina e tutta questa gente ti rovescia addosso se stessa. Chissà cosa pensi di noi, delle nostre stupide vite… Ti costringiamo a farne parte, ma non ti abbiamo mai chiesto il permessi – Un lampo illuminò il cielo sulle nostre teste e il rimbombo sordo di un tuono lo seguì. - Ma si vede lontano un miglio che tanto non te ne frega niente, nemmeno quando ci mettiamo a piangere o a urlare. – Grosse gocce di pioggia cominciavano a cadere. - No, non ti tocca la ***** nella quale noi soffochiamo ogni giorno. La sovrasti da un’altezza troppo incomparabilmente elevata perché possa riuscire anche soltanto a sfiorarti. Tu non sei qui insieme a noi, tu sei lontanissima. Cosa ti importa di mangiare? Mangiare serve solo a non morire. E cosa importa a te di ********* come la morte? – La pioggia si abbatteva con intensità sempre maggiore e le gocce cominciavano a infilarmisi nel colletto della giacca e a scendermi sul petto in rivoli gelidi facendomi rabbrividire. Mi sentivo pieno di una rabbia gelida e impotente che non avevo mai provato prima.
-Hai mai pensato al motivo per cui i cessi hanno le porte? – dissi alzando la voce fin quasi a urlare, stringendo i pugni nascosti dalle maniche della giacca. - Te lo dico io. Perché la nostra più grande paura è farci vedere mentre stiamo cagando. Che ci vedano nudi e dicano che siamo grassi, o troppo magri, che abbiamo il ***** piccolo, i brufoli sul **** o troppi peli. Tutto qua. E allora l’unica cosa a cui pensi è una porta per chiudere fuori il resto del mondo, così non riusciranno a vederti. Ma una porta non può fare nulla contro la paura, quella rimane con te, sempre. Non riesci a sopportare di sapere che ci sarà sempre qualcuno pronto a spiarti dal buco della serratura, o che si chinerà per guardarti dal pertugio sotto, per ridere dei tuoi segreti più rivoltanti. E invece di uscire e affrontarlo da uomo pensi a nasconderti meglio. Credi di risolvere i tuoi problemi incastrando un pezzo di carta igienica nella serratura, costruendo una barriera più efficace. Solo che a forza di stare al chiuso l’aria prima o poi si consuma. E allora, se vuoi continuare a respirare, rimane solo la paura. E buonanotte.
E buonanotte – ripetei incamminandomi con la testa incassata nella spalle e le mani in tasca, bagnato fradicio, sotto la pioggia che mi scrosciava addosso. Non saprei dire se stessi piangendo.
4.
La mattina dopo era domenica. Mi svegliai all’alba e quando capii che non sarei riuscito ad addormentarmi mi infilai i vestiti e scesi in strada. Il sole cominciava appena a risalire il suo percorso nel cielo luminoso e i suoi raggi si riflettevano attraverso l’aria pulita dalla pioggia sull’asfalto non ancora asciutto.
Lei, rachitica bambola, giaceva scomposta in una pozzanghera davanti alla panchina. Aveva vinto la fame
Non mi avvicinai, rimasi a guardare. Alle sette e mezza, quando aprì il bar e i fragranti aromi del caffè e del pane tostato si sparsero nella piazza, una cameriera con le tette grosse uscì fuori sorridendo. Guardò verso la panchina e il sorriso le morì sulle labbra. Esitò un attimo, poi corse da lei e la sollevò senza fare nessuno sforzo, tanto era leggera. Attraversò la piazza cullandola fra le braccia e, dopo aver fatto leva sulla barra con il piede, leggermente, la lasciò cadere nel primo bidone della fila.
5.
Per un po’ la gente che capitava da quelle parti aveva un’aria triste, svuotata. Passò del tempo e lentamente il senso di vuoto scemò finchè un giorno nessuno si ricordava più perché passando da piazza Dogana lo sguardo era involontariamente attratto da una certa panchina a righe verdi e blu, o a cosa fosse dovuto lo strano disagio che quella vista sembrava causare.
Come era destino che accadesse, ci dimenticammo di lei.