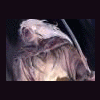@Sesbassar
Premessa: sono uno storico, che ha per un po' di anni frequentato anche la facoltà di psicologia e che ha studiato al liceo scientifico. In parole povere sono un umanista con una solida base scientifica o, meglio, sono un umanista il cui pensiero ha ricevuto un grande apporto, oltre che da quelle umanistiche, dalle materie matematico-scientifiche. Insomma, sono uno di quei forse abbastanza rari casi di mix disciplinare....tanto che per il mio modo di pensare non è possibile prescindere dalla collaborazione tra le varie discipline di studio per poter comprendere la realtà.
Ottima inserzione, molto interessante. 😉
Condivido del tutto l'idea che la Filosofia meriti ancora oggi pieno riconoscimento, non solo per il prezioso ruolo avuto nel nostro passato, ma anche e soprattutto per la sua ancora attuale e innegabile utilità per lo sviluppo del pensiero umano. Finché l'uomo sarà in grado di pensare, inevitabilmente farà filosofia. Perché, contrariamente a quello che molti scienziati cercano di affermare, non tutto il pensiero intellettuale è scientifico e non solo il pensiero scientifico è utile al progresso della conoscenza umana.
Condivido pienamente, inoltre, la condanna al positivismo.
Basta dire che per i positivisti discipline come la storia e la psicologia non erano scienze, in quanto le loro conoscenze non erano considerate sperimentabili empiricamente (non puoi vedere con i tuoi occhi com'era il medioevo, non puoi percepire concretamente i pensieri di un'altra persona). Non casualmente, invece, oggi diverse discipline umanistiche come la storia e la psicologia sono considerate a pieno diritto scienze, in quanto ad esse si applica il metodo scientifico, mentre si è finalmente accettato il fatto che non è scienza solo quel campo di studi che restituisce dati che lo sperimentatore può valutare con precisione grazie solo alla sua esperienza diretta. Tanto che, paradossalmente, pure le cosiddette scienze dure possiedono i loro casi di studio basati sull'incertezza: la Fisica Teorica fa costantemente analisi matematico-scientifiche su fenomeni che probabilmente non potrà mai osservare direttamente e su cui, dunque, potrebbe non avere mai certezza assoluta; la branca della matematica conosciuta come Teoria del Caos (consiglio la lettura del romanzo Jurassic Park per chi desidera averne una infarinatura di base) studia per sua stessa definizione l'imprevedibilità dei sistemi complessi, accettando pienamente l'idea che questi ultimi possano essere conosciuti e previsti solo nella sfera delle probabilità; e stesso problema della Teoria del Caos ce l'ha la più celebre Statistica, disciplina matematica che si basa sul calcolo delle probabilità e che, dunque, non potrà mai essere davvero certa che quello che prevede si realizzerà (basta notare come spesso i sondaggi politici sbaglino a descrivere la realtà elettorale di un paese).
Detto questo, ritengo (magari ho capito male io certi passaggi) che ci siano alcuni difetti di fondo nel tuo ragionamento su alcuni punti, "errori" che ho visto commettere a molti. E' solo la mia opinione, non sei obbligato a concordare. 😉
La ricerca di un senso della realtà è sicuramente una cosa preziosa, ma attenzione: solo perchè si sente il desiderio di trovare un senso e, riflettendo, se ne trova uno grazie a una tesi filosofica, non significa che la realtà poi abbia davvero quel senso. E' giusto non arrendersi all'idea che il mondo sia insensato o che non ci sia ragione per cercare un significato, ma anche il fatto di voler attribuire ad ogni costo un determinato senso alla realtà può essere un grave errore. Non poche persone, infatti, commettono lo sbaglio di appiccicare alla realtà un significato solo perchè ne sentono il bisogno o solo perchè quella teoria "sembra incastrarsi così perfettamente". Non è un errore che commettono solo filosofi e teologi, ovviamente, ma anche gli scienziati con le loro belle teorie. E' fondamentale cercare un senso...ma non bisogna presupporre alcuna risposta e, piuttosto, è necessario prepararsi all'idea di essere in errore. Sempre. E' solo così che il pensiero umano si evolve.
Dal tuo discorso (ripeto, potrei sbagliare) mi sembra trasparire un errore commesso da molti, ovvero il considerare il concetto di scienza pensando solamente alle scienze naturali (fisica, matematica, chimica, astronomia, biologia, ecc.). Nel tuo discorso, infatti, sembri parlare del mondo scientifico come di un settore totalmente pratico, incentrato solamente sull'analisi concreta della realtà, ovvero di quella sola porzione di mondo empiricamente dimostrabile. Per questo credo tu parli di un mondo scientifico che si è disinteressato della ricerca di un senso delle cose. Sembra, dunque, che - come molti fanno - tu ti sia dimenticato dell'esistenza delle scienze sociali, molte delle quali studiano proprio il senso che l'umanità attribuisce al mondo. L'Antropologia studia le culture umane e, dunque, il modo in cui l'umanità nei secoli ha percepito o percepisce ancora il mondo attorno a sè, come la valuta, come lo interpreta, come lo descrive; la Storia vuole comprendere ogni aspetto dell'esistenza umana, cercando di capire perchè l'uomo ha agito e agisce in certi modi (e il perchè delle azioni dell'uomo è stabilito anche dal senso che l'uomo attribuisce alla realtà); la Psicologia studia il pensiero umano e i modi in cui le persone percepiscono sè stesse e il mondo che li circonda; e così via. Attenzione, insomma, a non commettere tu un errore paradossale: finire intrappolato nella visione positivista della scienza, dimenticando di considerare che la scienza di oggi non è solo rivolta allo studio dei fatti concreti, pratici, matematici, ma anche alla ricerca della comprensione della realtà umana (ovvero quel significato di cui tu parlavi). 😉
L'idea che Filosofia e Scienza non si pestino più i piedi tra loro, secondo me, non solo è impossibile, ma nemmeno auspicabile. Parlando di filosofie, infatti, se c'è che una cosa che la storia ha ampiamente dimostrato nei millenni è che l'esistenza è lotta costante: ogni cosa è in costante lotta con tutto il resto del mondo, per sopravvivenza o affermazione; anche se può sembrare un processo crudele, è la lotta ciò che consente il progresso, perchè costringe all'evoluzione e al perfezionamento. Scienza e Filosofia saranno sempre in lotta fra loro, perchè vivono del medesimo campo di studi: la comprensione della realtà che ci circonda. Studiando la stessa cosa prima o poi si trovano inevitabilmente costrette a rivaleggiare, a litigare per dimostrare chi ha ragione, a lottare per mantenere il controllo sulla loro fonte di sussistenza, ovvero il loro campo di studi. Ed è un'ottima cosa che sia così. E' questo tipo di concorrenza che costringe le due discipline a perfezionarsi, a tirare fuori nuove idee e a contribuire nel far progredire la conoscenza umana. Anzi, entrambe le discipline sono preziose, perchè l'una contribuisce a rispondere alle incognite lasciate aperte dall'altra. Pretendere che le due discipline evitino di infastidirsi tra loro, invece, significa solo rischiare che - pur di non invadere il campo dell'altra - esse smettano di essere in grado di far progredire la conoscenza. La storia ha ampiamente dimostrato, infatti, che nel tempo alcune discipline possono aiutare a trovare nuove risposte in campi che altre discipline ritenevano già definitivamente spiegate. Le discipline di studio DEVONO pestarsi i piedi tra loro e, se possibile, magari anche collaborare tra loro per consentire all'uomo di sviluppare ancora meglio la sua comprensione del mondo.